 |
| Leonardo Sinisgalli, in una foto di Federico Patellani |
Che libro meraviglioso è
L'età della luna! Fu pubblicato nello Specchio mondadoriano
nel 1962. Leonardo Sinisgalli, che ne è l'autore, aveva allora 54
anni, viveva a Roma e di tanto in tanto si recava a Montemurro, il
paese della Lucania dove era nato e che torna spesso nei suoi versi.
Era poeta, ingegnere, matematico, curava la pubblicità per Eni e
Alitalia. In passato aveva diretto il settore pubblicità della
Pirelli e fondato e guidato la rivista di cultura scientifica La
civiltà delle macchine.
L'età della luna
è un prosimetro, una raccolta di prose e poesie (ma forse sarebbe
meglio dire testi poetici in prosa e testi poetici in versi), scritte
tra il 1956 e il '62. Il testo che apre il libro, Poesia, si
compone di un solo rigo (o è un verso?): “L'amore del Poeta è la
realtà che egli distrugge”.
Nel corso del libro si
parla spesso di poesia, con tono sentenzioso, sorpreso, ironico,
divertito. In una prosa che fa parte della sezione L'immobilità
dello scriba, Sinisgalli afferma che i critici svolgono
“operazioni chirurgiche, alcune assai delicate (…) con la benda
davanti alla bocca per arrivare al midollo spinale del povero poeta
smidollato”. I critici “cercano la logica nei poeti”, ai quali
giova però soprattutto “la loro innocenza”. Sinisgalli confessa:
“Il mio sforzo di scrivere versi è stato appunto il disprezzo
della mia saggezza”. E poi: “Credo di non sapere ancora quale sia
precisamente il mestiere di poeta”.
Disprezzare la propria
saggezza può anche significare non predisporre ma raccogliere. Il
poeta insomma non si muove convinto verso un punto d'arrivo, verso
l'obiettivo programmato, perché non ha un progetto. Non sa nemmeno
capire perché il suo discordo sia partito proprio da quel verso,
cosa l'abbia indotto a cominciare da lì.
Sinisgalli conclude: “I
versi hanno una concatenazione che non si rivela in superficie.
Convergono verso un punto che le stratificazioni possono nascondere a
qualunque scandaglio, un cuore introvabile”.
Questo non significa che
la parola della poesia debba essere oscura per statuto, ma solo che
forse il mestiere del poeta, anche del poeta che più nitidamente ci
consegna i suoi versi, è quello di rendere introvabile il cuore
della poesia, di sapere che se una logica esiste è nascosta sotto le
stratificazioni dei versi. Lì, in un luogo che non si rivela, c'è
qualcosa che si muove continuamente, che cambia di forma e di colore.
Il mestiere di poeta (non
lo dice lo stesso Sinisgalli ad inizio del libro?) è fondato intorno
all'atto di distruggere la realtà, anzi intorno alla consapevolezza
che, agli occhi di chi la ama, la realtà non può che apparire
distrutta: scomposta, baluginante, rarefatta. E il poeta non può che
tentare, all'infinito, di ricomporre in unità la parole, per dire la
frammentazione della realtà.



.jpg)




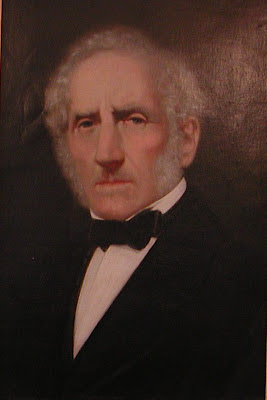
_-_ritr._A_Ferrazzi,_Recanati,_casa_Leopardi.jpg)








