All'amato Philip Larkin,
con il quale condivide il gusto per l'imprevista sentenza e lo
sguardo disincantato e divertito sull'opacità della vita quotidiana,
Attilio Lolini affida, nell'ultima Imitazione che
chiude la sua nuova bellissima raccolta di poesie Carte da
sandwich, una sorta di definitivo ritratto di se stesso: “come
sono sereno / come sono disperato”. La poesia di Lolini è tutta in
questa paradossale confessione: insieme serena e disperata di fronte
all'inconcludente nostra presenza nel mondo, non può più
meravigliarsi né reagire con rabbia, poiché tutto è già saputo,
pur restando ogni cosa irrimediabilmente sconosciuta. Ogni atto del
nostro vivere, anche il più ordinario, dice che non esiste via di
fuga, e dunque i versi del poeta possono solo registrare, con parole
limpide e senza infingimenti, le immagini ripetitive del carcere in
cui siamo costretti: “Le stagioni si ripetono / come dischi rigati
// della libertà / ci siamo liberati”.
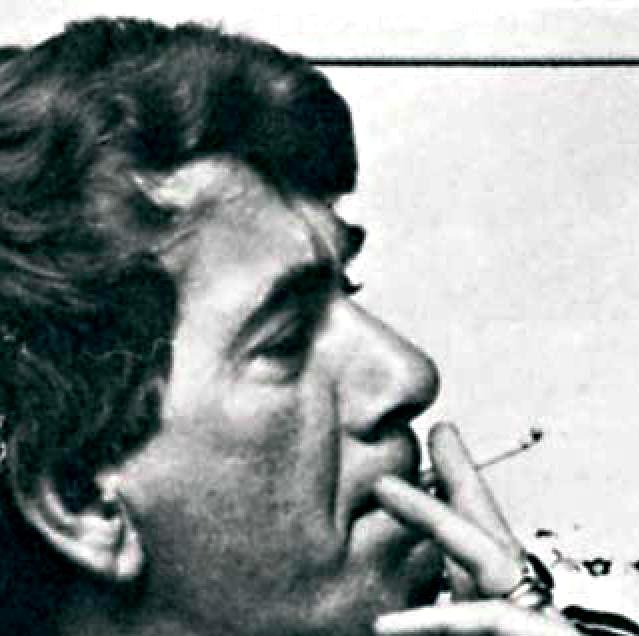 Non c'è da rimettere
insieme i pezzi, non esiste ipotesi di ricomposizione, le nostre
occupazioni sono “insensate”, le tappe “già segnate” (“Mi
pare di sapere / come è andata // tutta la vita / una passeggiata /
scombinata”), nemmeno il cielo regala consolazione (“Zoppica il
sole / salendo verso il cielo // arranca e va di sbieco / come un
uccello cieco”). Al poeta resta solo lo sguardo senza illusioni, il
procedere beffardo e lieve sulle macerie, la consapevolezza che anche
la poesia non ha parole definitive da offrire, anzi “la poesia
abita / una vecchia culla / nasce felice / se non dice nulla”.
Non c'è da rimettere
insieme i pezzi, non esiste ipotesi di ricomposizione, le nostre
occupazioni sono “insensate”, le tappe “già segnate” (“Mi
pare di sapere / come è andata // tutta la vita / una passeggiata /
scombinata”), nemmeno il cielo regala consolazione (“Zoppica il
sole / salendo verso il cielo // arranca e va di sbieco / come un
uccello cieco”). Al poeta resta solo lo sguardo senza illusioni, il
procedere beffardo e lieve sulle macerie, la consapevolezza che anche
la poesia non ha parole definitive da offrire, anzi “la poesia
abita / una vecchia culla / nasce felice / se non dice nulla”.
Il sentimento del comico
nasce in Lolini proprio dalla costatazione dell'assoluta insensatezza
delle nostre azioni. Il male di vivere è possibile
raccontarlo solo prendendoci in giro, denunciando la nostra incivile,
a tratti vile, arroganza di uomini che credono di avere un posto e
una ragione che dia conto degli affanni che quotidianamente
affrontano. Né può valere a qualcosa tentare di mettere ordine nel
disordine generale, azzardare delle risposte, cercare rifugio in
un'ipotetica superiore saggezza: “Tante citazioni presumo / da
libri letti e abbandonati / la solita solfa di chi campa // con il
solito finale: / poco ci è dato conoscere / quel poco sono errori di
stampa”.
La poesia di Carte da
sandwich ha la capacità di farci ridere proprio mentre
contempliamo le nostre miserie. E' una poesia che genera un continuo
senso di spaesamento: non permette al lettore di muoversi dalla linea
tracciata, e in questo modo lo incatena al suo niente; lo illumina
con splendenti motti di spirito ma solo per accecarlo. Insomma Lolini
non è un poeta che utilizza le parole perché il mondo sembri più
bello, non vuole consolarci né essere buono, anzi è consapevolmente
cattivo, quando si aggira, sentenzioso e sorridente, cantando le sue
ariette leggere, sereno e disperato, intorno ai nostri mali,
costringendoci a riderci sopra. La sua poesia non cerca di
sottintendere né alludere, non vuole ammansire la realtà con un
linguaggio evocativo o oscuro, è da cantare a bassa voce, in una
tonalità in minore, senza nessun accento declamatorio.
Non serve andare lontano
per capire come va il mondo: l'epica di Lolini è delimitata a pochi
oggetti vicini, ai paesaggi circostanti, tanto che ci si sente già
senza patria in un'altra contrada, “dall'altra parte del fiume /
nella remota rosticceria Tom & Jerry”, lì dove “gli esuli
fischiettano canzoni”. Dai suoi versi a rima baciata, dai versicoli
antiungarettiani, dal parodistico e irridente gioco melodico, emerge
un personaggio, non più arrabbiato, come accadeva nelle sue poesie
degli anni Settanta e Ottanta, ma malinconico e indolente, che
ritorce lo sguardo malizioso anche contro se stesso: “Fui
progressista / lessi i libri giusti, feci discorsi alla moda /
davanti ai professori mossi la coda / sempre spinto da penose
fantasie / da pensieri fuori corso // il tempo ci smembra come un
coltello affilato / calcolo le sigarette che ancora fumerò / le
inutili pagine che ancora stamperò”.
La voce di Attilio Lolini
è una delle più intense e originali della poesia italiana degli
ultimi decenni, le sue pagine non sono state e non saranno, ne siamo
certi, inutili. Peccato che solo da pochissimi anni, complice il suo
fare appartato e poco compiacente, la grande editoria si sia accorta
di questo poeta nato nel 1939, fin dalle prime prove capace, come
subito intuì Pasolini, di fotografare con spietata e leggerissima
esattezza la nostra comune disperazione.
(pubblicato sulla rivista Il Grandevetro)


