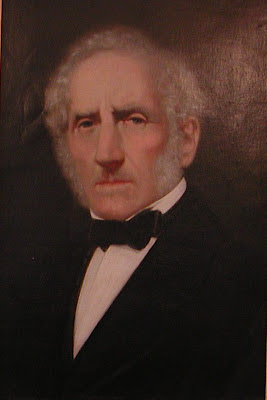Una delle pagine più
tristi della storia europea degli ultimi decenni è stata ricordata
con la solita distratta e frettolosa modalità che nel nostro paese,
e forse nella nostra civiltà, si riserva agli avvenimenti che
disturbano le nostre coscienze e che contrastano con il desiderio di
vivere comunque in superficie. La guerra in Bosnia ed Erzegovina
cominciò nell'aprile di venti anni fa. L'assedio della città di
Sarajevo divenne il cupo simbolo di un conflitto atroce e per tanti
versi inspiegabile. A poche centinaia di chilometri dalle nostre
coste venivano cancellati decenni di convivenza pacifica di fedi ed
etnie diverse, che nella città bosniaca avevano avuto modo di
confrontarsi e di dare vita a una cultura ricca ed originale.
| Osti a Pistoia nel 2006 (foto Andrea Pecchioli) |
Josip Osti è uno dei
massimi esponenti del ricco panorama letterario dei paesi che sono
nati dalla dissoluzione della Jugoslavia. Il suo mondo poetico si
nutre di immagini e di situazioni semplici, tratte da vicende della
vita quotidiana, spesso sviluppate attraverso un una modulazione di
carattere narrativo. Il tono, apparentemente dimesso e senza dubbio
di sobria inflessione, si produce improvvisamente in un lirismo di
grande potenza evocativa, che nasce sempre dalle piccole cose, dai
minimi accadimenti di ogni giorno, lasciando emergere da essi
significati profondi e inaspettati.
E' il caso, ad esempio,
della poesia che riporto di seguito, tratta da Il timbro di
Salomone. La traduzione è di Jolka Milic.
Non c'è più la
tabaccheria all'angolo
Non c'è più la
tabaccheria all'angolo. La tabaccheria
intorno alla quale
ronzavo per giornate intere cercando
di vincere l'indomabile
pudore giovanile, fino a quando non mi
feci coraggio e andai a
comprare il mio primo preservativo.
Non c'è la vecchia
tabaccaia che dalla mia mano sudata e
tremante prese la
banconota e me lo diede con lo stesso gesto
lento con il quale mi
consegnava anche le sigarette, comprate a
pezzo, per mia madre. Non
c'è più la profonda voce vellutata
con la quale mi chiamò,
come chiamava tutti quelli che
dimenticavano di ritirare
il resto. Non c'è più il suo viso bonario
che pareva non cambiasse
mai. Era uguale anche quando, dopo
parecchi anni, con
l'eletta del mio cuore acquistai da lei qualche
dozzina di preservativi,
pretendendo perfino quelli più grandi e
colorati che dopo,
ridendo e scherzando, avevamo gonfiato
ornando con essi la
stanzuccia dove festeggiavamo il capodanno.
Non c'è più la
tabaccheria all'angolo, come non c'è più la metà
degli edifici del rione
dove una volta abitavo.
(da
L'albero che cammina,
Multimedia edizioni)